Categoria: Cinema
-

La verifica incerta, ovvero l’attualità di Videodrome
Il cinema di David Cronenberg ha puntato all’eccesso le sue analisi. Ma non ha sbagliato.
-

Dune: le sabbie della distruzione
Il nuovo film di Denis Villeneuve, personale trasposizione della prima parte del romanzo di Frank Herbert.
-

Città tumorali: i grattacieli e le catacombe di Metropolis
La città futuristica di Fritz Lang e il suo sviluppo estremo
-

Spider-Man: un nuovo universo metamediale
Il personaggio metabolizzato e autocosciente del film di animazione Marvel/Sony
-

La genitorialità ai tempi degli zombi
Il ruolo dei genitori verso figli bambini e adolescenti nel cinema dei morti viventi.
-
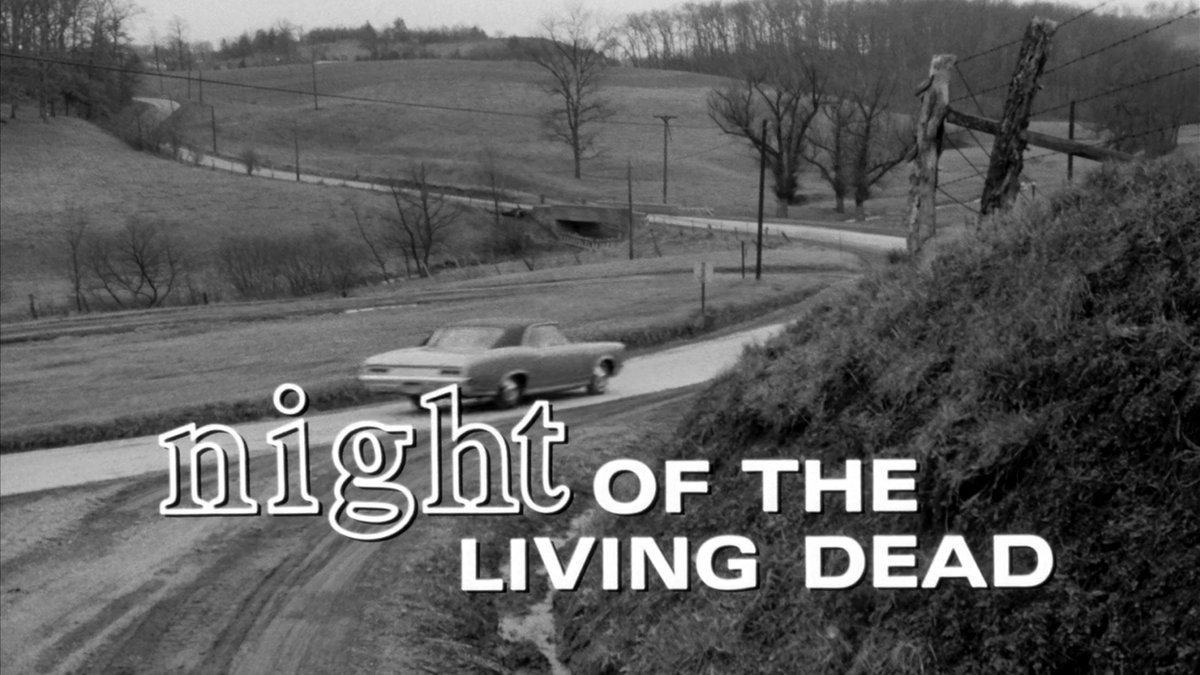
La notte dei morti viventi
Orrore e ribellione nel rivoluzionario capolavoro di George A. Romero a cinquant’anni dalla sua uscita.
-

Storia di un fantasma e dell’ineluttabile lentezza del tempo
Cronaca visuale di un disperato amore oltre la morte e il tempo in una ghost story di David Lowery
-

A Quiet Place, il coinvolgente suono del silenzio
Il film fanta-horror di John Krasinski rompe il muro del suono e coinvolge lo spettatore con una piccola famiglia e il suo silenzio obbligato.
-

The Shape of Water: una forma del cinema liquido
L’acqua e le sue infinite forme e metafore liquide nell’ultimo film di Guillermo Del Toro, regista messicano di un cinema dalle infinite mutazioni.
-

Blade Runner 2049: la solitudine del futuro
A trentacinque anni dal classico del cinema Blade Runner di Ridley Scott, arrivano i nuovi replicanti nella visione di Denis Villeneuve.
-

Paterson, una vita perfettamente normale
Un film di Jim Jarmush sulla perfetta normalità della vita, un antidoto ai film cupi, d’azione o eccessivamente drammatici.
-

Perché ci piacciono i film catastrofici?
Che cosa ci spinge a guardare un film catastrofico? Che cosa cerchiamo in uno spettacolo in cui persone come noi, per cui dovremmo provare empatia e compassione, sono esposte a tremendi pericoli, perdono la vita in modi più o meno orribili in incendi, terremoti, impatti con meteoriti, esplosioni nucleari?
-
Star Wars VII – Il non risveglio della Forza
La quarantennale saga di Guerre Stellari arriva al settimo capitolo, senza George Lucas e con troppe ripetizioni e svariati sbadigli.
-
L’arrivo di un treno: da La Ciotat a Pordenone
Una trasmissione Periscope chiude (per me) il cerchio aperto dai fratelli Lumière.
-
A qualcuno piace caldo, ovvero la falsità secondo Billy Wilder
Il falso, tra dramma e commedia, come motore perpetuo del cinema del regista Billy Wilder.
-
Mad Max: Fury Road – La strada furiosa di George Miller
Il nuovo capitolo/reboot della saga post apocalittica di George Miller è una scheggia impazzita e adrenalinica di puro cinema d’azione.
-
Videodrome, il ciberspazio metaforico di David Cronenberg
Viaggio allucinante nella società dello spettacolo dal punto di vista del regista canadese della mutazione.
-
Tetsuo, l’arma umana di Shinya Tsukamoto
La mutazione dell’uomo-macchina secondo il regista giapponese Shinya Tsukamoto e i suoi film sperimentali al limite dell’umano.
-
La catastrofe come malattia: Take Shelter
La catastrofe per visualizzare le paure di un padre di famiglia americano e quelle degli Stati Uniti a dieci anni dall’11 settembre.
-
Il fantasma della democrazia
I morti viventi come rappresentazione della paura di evoluzione del sistema democratico.
-
Morti fuori e morti dentro
Agorafobia e claustrofobia nei film di zombi.
-
Lo zombi come consumatore finale
La metafora della società dei consumi in Zombi di George A. Romero
-
Il giorno degli zombi come apocalisse laica
Il cinema dei morti viventi e la risurrezione senza religione.
-
Dead Set, o la televisione dei morti viventi
Zombi e pubblico televisivo nella satira inglese di Big Brother
-
Tutti i colori di “2001: odissea nello spazio”
Il colore nel film tavolozza di Stanley Kubrick.
-
Morti che camminano e morti che corrono
Insieme a 28 giorni dopo, L’alba dei morti viventi inaugura un nuovo tipo di zombi.
-
H.R. Giger, l’alieno biomeccanoide
Se n’è andato il creatore di Alien e di altri splendidi incubi.